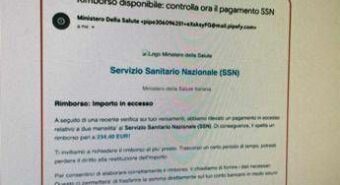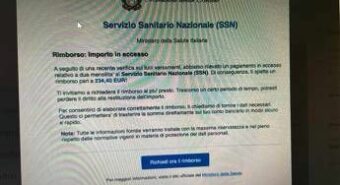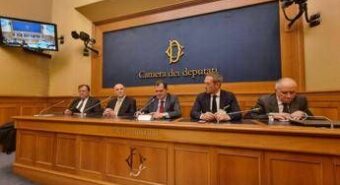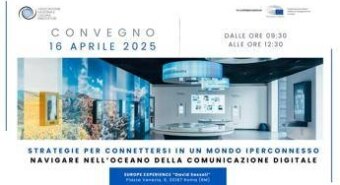Cambiamento climatico, il ruolo di Hera nell’Emilia-Romagna che si adatta
Nella prima puntata italiana, il webdoc Adaptation racconta le migliori pratiche di adattamento al cambiamento climatico espresse in regione. Mettendo al centro l’acqua, questo viaggio virtuale conduce così alla scoperta del servizio idrico di Hera che, grazie a pianificazione, infrastrutture e tecnologie all’avanguardia, contribuisce con investimenti per oltre 100 milioni di euro all’anno alla preservazione della risorsa e alla sicurezza del territorio.
Fra le risorse naturali che maggiormente risentono degli effetti del cambiamento climatico c’è sicuramente l’acqua, un bene di fondamentale importanza che – oggi più di ieri - dev’essere consumato responsabilmente e gestito secondo le migliori soluzioni possibili, prendendo ad esempio i casi in cui esse vengono già adottate.
I ritardi del Paese e l’eccellenza emiliano-romagnola: le ragioni di un successo da replicare
Una proposta, in questo senso, arriva dalla prima puntata italiana, da oggi navigabile online, del webdoc Adaptation, progetto di “constructive journalism” dedicato alle migliori esperienze di adattamento al cambiamento climatico. Affrontando il caso emiliano-romagnolo e la sua situazione idrica, Adaptation mette infatti in evidenza le tante eccellenze amministrative, industriali, scientifiche e civiche grazie alle quali questa regione – in controtendenza rispetto a gran parte del Paese – si sta adattando con efficacia a una delle sfide più decisive del nostro tempo. Cruciale, in tutto questo, il ruolo di Hera, secondo operatore a livello nazionale nel settore idrico.
Hera, l’invisibile industria che risponde ai bisogni di 3,5 milioni di abitanti
Aprendo le proprie porte alla squadra di Adaptation, Hera l’ha condotta alla scoperta di progetti, impianti, reti, laboratori, tecnologie e interventi infrastrutturali che qualificano la multiutility come attore decisivo per l’equilibrio idrico complessivo del territorio. Un servizio spesso invisibile ma fondamentale per preservare una risorsa così preziosa e renderla disponibile ogni giorno a oltre 3,5 milioni di persone. Fin dalla sua nascita, e anticipando così gli scenari odierni, il Gruppo Hera ha infatti investito più di 100 milioni di euro all’anno in questo delicato settore, riuscendo a mettere in sicurezza il servizio idrico integrato e a garantirne la continuità anche in situazioni particolarmente critiche. Tutto questo passa attraverso un modello di business resiliente e un forte radicamento territoriale, che invita cittadini e imprese all’uso responsabile e sostenibile della risorsa e nell’ambito del quale è proprio Hera, per prima, a dare l’esempio, con una politica di costante e progressiva contrazione dei consumi idrici delle proprie attività.
Potabilizzazione, distribuzione e depurazione, ma anche tecnologie all’avanguardia
Fra lunghe sequenze di immagini immersive e le voci dei professionisti che ogni giorno fanno la differenza sul campo, sono davvero tanti gli aspetti esplorati da Adaptation, a partire dal tema – oggi quantomai critico - dell’acqua potabile. Come emerge dal racconto, Hera ne garantisce non soltanto la qualità, attraverso impianti di potabilizzazione e laboratori di analisi assolutamente all’avanguardia, ma anche e soprattutto la disponibilità, attraverso un sistema di acquedotti vasti e interconnessi sempre più sensibili, gestiti anche da remoto attraverso il proprio centro di telecontrollo, unico in Europa, e ulteriormente monitorati da tecnologie avanzate, come quelle satellitari, per la ricerca e la costante riduzione delle perdite idriche.
Un’altra fondamentale sfida è quella relativa alle acque reflue, che vengono trattate dalla multiutility nei depuratori secondo tecniche e tecnologie diverse, biologiche e meccaniche, affinché sia possibile restituirla all’ambiente in una forma compatibile con ulteriori usi umani, ma anche con gli ecosistemi e la loro biodiversità, perseguendo così la piena circolarità nella gestione della risorsa. Tra le eccellenze del comparto fognario-depurativo al centro di Adaptation, in particolare, il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini, il più grande intervento di risanamento fognario realizzato in Italia negli ultimi vent’anni, con l’obiettivo di eliminare gli sversamenti a mare e proteggere così, al tempo stesso, l’ambiente e la spiccata vocazione turistica dell’economia locale.
La sperimentazione modenese nella depurazione
Fra le esperienze emiliano-romagnole raccontate da Adaptation c’è anche il depuratore di Modena. Proprio in questo impianto, infatti, è presente uno dei sistemi più all’avanguardia per la gestione di alcune importanti fasi del trattamento dei reflui. Si tratta di un sistema di controllo applicato alle vasche di ossidazione che utilizza logiche predittive di intelligenza artificiale. Il fine? Conoscere in anticipo le concentrazioni dei flussi in uscita dall’impianto, così da regolare al meglio il processo depurativo, ottimizzare i consumi di energia e migliorare la qualità dell’acqua depurata. E poiché questi risultati non erano ottenibili con strumenti di controllo tradizionali, sul depuratore di Modena è stato impiegato in via sperimentale un controllore predittivo, basato su modelli di intelligenza artificiale. Sfruttando algoritmi di Machine Learning, questo controllore comprende la natura dinamica del sistema, ne regola automaticamente alcuni parametri e, così facendo, contribuisce ad abbattere ulteriormente rispetto ai limiti di legge la concentrazione di sostanze presenti nelle acque in uscita dal depuratore, come l’azoto.
“Di fronte al cambiamento climatico non abbiamo bisogno di catastrofismi ma di risposte resilienti ed esempi concreti – commenta Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – e per questo abbiamo apprezzato l’approccio del progetto Adaptation e deciso di fornire tutta la nostra collaborazione. Aprire le porte dei nostri impianti è stato quindi un piacere e anche motivo di orgoglio, perché il modo in cui ogni giorno gestiamo la risorsa idrica è frutto non soltanto di investimenti, pianificazione e ricerca ma anche di tanto impegno, lo stesso che ci auguriamo possa animare un dibattito pubblico che deve assolutamente tornare a mettere al centro, con serietà e senza scorciatoie, il tema del cambiamento climatico e delle strategie necessarie ad affrontarne e mitigarne gli effetti.”
EMILIA ROMAGNA, PRIMA TAPPA ITALIANA DEL WEBDOC
L’adattamento è un’avventura, una sfida per la convivenza con il cambiamento climatico che riguarda tutti. In questo senso l’Emilia Romagna è un ‘laboratorio a cielo aperto’ dove tante buone pratiche per resistere agli sconvolgimenti della natura sono state già messe in campo.
Parte da qui il racconto, diviso in capitoli, fatto dal team di giornalisti di ADAPTATION (questo il nome del webdoc online all’indirizzo www.adaptation.it ) che ha visitato la regione lo scorso settembre e realizzato interviste a esperti di gestione del territorio, accademici, forestali, ingegneri e climatologi.
A parlarne, nella tavola rotonda trasmessa via ZOOM lunedì 14 dicembre, sono stati quattro ‘addetti ai lavori’ di alto livello, la dott.ssa Marta Ellena, ricercatrice del CMCC, il dott. Luca Salice, partner di ADAPTATION, il prof. Stefano Pareglio, docente di Economia ambientale presso l’Università Cattolica di Milano e Coordinatore scientifico di FACTS/FEEM e il dott. Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. Ognuno degli speaker ha portato un contributo molto interessante alla discussione. Adattamento in ambito urbano e oggetto di negoziati internazionali, adattamento del business e racconto giornalistico di un fenomeno così complesso all’interno della narrazione sul cambiamento climatico, questi i temi intorno ai quali si è sviluppato il dibattito. Moderatore dell’incontro il giornalista Emanuele Bompan, direttore della rivista Materia Rinnovabile.
Dopo la prima puntata dedicata all’Olanda, il team di ADAPTATION ha dunque iniziato a viaggiare nelle regioni italiane per raccontare come si stiano adattando al cambiamento climatico. La prima puntata di questo “italian grand tour”, non a caso, è dedicata all’Emilia Romagna, una regione che nel 2018 ha varato il suo piano di adattamento.
Tema centrale del ‘viaggio’, è stato l’acqua. Il suo ciclo di vita, i suoi usi, la salvaguardia, la rigenerazione e la valorizzazione della risorsa, gli investimenti per difendersi dalle esondazioni, l'impatto sulla popolazione.
Le collaborazioni nate sul campo sono state decisive per la riuscita del lavoro. Dal CNR al Consorzio di Bonifica Renana, dall’Autorità di Bacino di Distretto del Fiume Po all’Ecovillaggio Montale, dal Consorzio di Bonifica della Romagna al Gruppo Hera, che ha aperto le porte dei suoi impianti e mostrato tecnologie di frontiera.
Se in Emilia Romagna si sta facendo tanto, in altre parti del Paese la situazione appare meno rosea. L'Italia versa in uno stato di crisi idrica strutturale, causata da numerosi e concomitanti fattori: eccessivo water footprint, perdite nelle reti, condizioni climatiche sempre più estreme, spreco della risorsa e mancato o insufficiente riuso.
Secondo recenti studi (confortati da azioni di monitoraggio portate avanti nel tempo in tutta la penisola) mancherebbero all'appello 23,4 miliardi di metri cubi d’acqua. Vale a dire una quantità pari a quella contenuta nel lago di Como.
Per essere ancora più chiari, nel 2020 stiamo sperimentando la peggiore crisi di siccità mai verificatasi negli ultimi 60 anni. Significa meno acqua da bere, ma anche meno acqua per la nostra agricoltura, che da sola consuma ben il 70% di tutta l’acqua dolce disponibile.
Negli ultimi 20 anni, poi, la siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro.
Dinanzi ad uno scenario del genere appare evidente che il risparmio d'acqua, la manutenzione e il monitoraggio technology-driven delle reti, la cultura del riuso, la depurazione, il controllo qualità, le buone pratiche di uso (da parte dell'utilizzatore finale) rappresentino le condizioni necessarie per la costruzione di un modello di vita sostenibile e rispettoso della 'risorsa acqua'.
Allo stesso tempo, per la crescita di una comunità realmente resiliente e 'adattata' occorrono pianificazione, investimenti e infrastrutture importanti, come le enormi ‘vasche’ scavate sotto piazzale Kennedy, nel pieno centro di Rimini, per farvi convergere acque piovane e reflue in eccesso ed evitare che vengano sversate in mare (si tratta di uno dei principali interventi del cosiddetto PSBO, Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato).
Tutto il capitolo Adaptation sull’Emilia-Romagna è già disponibile online, lo trovi qui:
- Il trasporto pubblico che vorrei, le associazioni lo disegnano con Amo
- Mercato libero, Emilia-Romagna in linea con la media nazionale sulla luce, mentre il gas cresce meno che nel resto d'Italia
- Unimore ha conferito il titolo di professore emerito a Sonia Bergamaschi e Luigi Grasselli
- Modena parla inglese, boom di turisti stranieri in Acetaia comunale
- Sonia Bonfiglioli designata nuova presidente di Confindustria Emilia per il quadriennio 2025-2029
- Autobus, dal 23 aprile a Modena 50 corse in più sulle linee 1, 7 e 8
- Strada deformata, limite dei 30 km/h sulla via Giardini tra Maranello e Serramazzoni
RESTO D'ITALIA E MONDO
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.